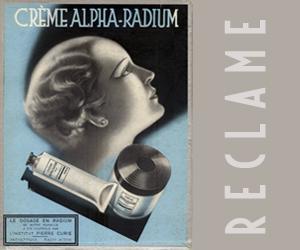inchiniamoci all’inchinato
La vita di Vic Chesnutt ha toccato gli apici della bellezza artistica e gli abissi del dolore. Ha composto e cantato, nel corso della sua carriera, canzoni meravigliosamente vere, struggenti, furiose, delicate, disarmanti. Ma ha anche vissuto una delle esistenze più complesse e lacerate che il panorama musicale americano recente abbia conosciuto.
Nato a Jacksonville, Florida, nel 1964, Vic cresce nella provincia meridionale degli Stati Uniti, immerso nell’eco della musica country, tra religione e solitudine. A 19 anni, nel 1983, è vittima di un incidente automobilistico: perde il controllo dell’auto sotto l’effetto dell’alcol. L’impatto lo lascia parzialmente paralizzato. Da allora si muove in sedia a rotelle, con un uso estremamente limitato delle mani — tanto che per tutta la sua carriera suonerà la chitarra con pochi, minimi movimenti delle dita.
Per molti anni al suo fianco c’è Tina Chesnutt, compagna di vita e bassista, spesso presente anche nei suoi dischi, come in Ghetto Bells. Ma la loro relazione, col tempo, si incrina. Si separano poco prima della fine, e anche questa perdita si deposita nel fondo della sua voce.
Il 25 dicembre 2009, nel giorno di Natale e del suo 45º compleanno, Vic muore ad Athens, Georgia, per overdose di farmaci. Aveva detto più volte — in modo più o meno esplicito — che non ce la faceva più. Nemmeno a sostenere le spese mediche per la sua salute. È stato l’ultimo atto di un’esistenza tragicamente coerente, attraversata dal dolore, dalla poesia e da una lucidità spietata.
Ghetto Bells: un’eleganza obliqua, claudicante, notturna
Con Ghetto Bells, uscito nel 2005 per la New West Records, Chesnutt realizza uno dei suoi lavori più eleganti e articolati. La sua scrittura resta claudicante, imperfetta, ma qui si avvolge in un abito sonoro più curato, notturno, barocco e fragile. È un disco che struttura senza irrigidire, che abbellisce la sua arte, senza mai addolcirla.
La voce di Vic — corrosiva, un po’ nasale, ferma negli attacchi e tesa nei ritardi — non perde la sua ruvida autenticità, ma in Ghetto Bells assume un nuovo splendore: canta come trattenendo il respiro, con un fraseggio a denti stretti che punge, vibra e lascia traccia.
A produrre l’album è John Chelew, nome di grande esperienza, già al lavoro con John Hiatt e Richard Thompson, capace di costruire atmosfere cinematiche senza mai sovrastare l’interprete. Ma i due elementi davvero decisivi nel suono di Ghetto Bells sono Bill Frisell e Van Dyke Parks.
Bill Frisell, chitarrista americano tra i più importanti del jazz contemporaneo, ha costruito una carriera su una chitarra che suona come un pensiero liquido. Il suo stile combina elementi country, jazz, ambient, improvvisazione libera e silenzi. In Ghetto Bells, Frisell accompagna, accarezza le armonie (la sua presenza è centrale in brani come Forthright), suggerisce direzioni, con la sua chitarra dal suono ampio, come suggeriscono le note di copertina.
Van Dyke Parks, musicista colto e atipico, è noto per i suoi arrangiamenti orchestrali raffinati (celebre la sua collaborazione con Brian Wilson per Smile). Qui mette a disposizione il suo accordeon luminoso e malinconico, il suo pianoforte, l’organo e firma l’arrangiamento d’archi di Virginia. Il suo apporto eleva i brani a un livello di delicatezza quasi cinematografica: la sua scrittura non riempie, ma vibra tra le pieghe della voce di Vic.
Il risultato è un disco oscuro, 11 tracce che, come braci sul fondo del camino, luccicano da dentro. L’eleganza di Ghetto Bells non è patinata, ma screziata: il riflesso della luna sulla notte di un deserto petroso.
Brani selezionati – piccole ferite nel cuore dell’abisso
Il cuore di Ghetto Bells pulsa in queste sette tracce scelte, illuminate da tensioni accumulatesi tra parole smozzate e note sospese:
Virginia
Con un folgorante valzer tragico, aperto dagli archi di Parks, formidabili, malinconici e severi che convergono sulla voce di Vic. Ecco come inizia Ghetto bells. Virginia è figura enigmatica — madre, amante, patria — e il coro Yes, Virginia, I love you… Too much to survive è un’affermazione d’amore che uccide.
Il testo è una confessione ambigua, quasi edipica: si parla di una donna, ma anche di un’origine, di una terra, forse dell’America stessa. L’amore per Virginia è profondo e velenoso, come la nostalgia di chi ama ciò che lo distrugge.
Little Caesar
Un brano cupo, sorretto da un groove percussivo lento, da marcia funebre. Little Caesar è un’allegoria politica e infantile allo stesso tempo: il potere come gioco crudele, il bambino come piccolo tiranno. Il tono è ossessivo, sarcastico, quasi minaccioso. Vic costruisce un personaggio che somiglia a certi leader contemporanei: inquietanti e irrimediabilmente minori.
What Do You Mean?
Il fulcro lirico e formale del disco: un dialogo a due voci tra Vic e la nipote, Liz Durrett, pieno di immagini folgoranti:
Like a puppy on a trampoline/ What do you mean?/ Bewildered
L’immagine di apertura è formidabile nella sua semplicità: un cucciolo su un trampolino, figura che rende alla perfezione il senso di spaesamento, di vulnerabilità infantile e goffaggine gioiosa che permea tutto il brano. Non è solo una metafora dell’handicap, né solo un autoritratto tenero e grottesco. È un simbolo universale di quanto sia impossibile restare in equilibrio quando non se ne ha la possibilità. Il termine “Bewildered” — smarrito, sconcertato — viene lasciato cadere come una diagnosi. Ne nasce un dialogo agrodolce, sostenuto dalla sola chitarra acustica di Vic, in cui persino la felicità diventa un mistero, una risata lontana, irrinunciabile quanto irraggiungibile
We heard you laughing / What do you mean? / Felicity
Poi la vita diventa suono e noi surfisti incerti: It is a vibration / It moves in a wave / You are a surfer on that clarion tone
Una delle frasi più poetiche di tutto il disco: la coscienza come un’onda, e noi sopra, incerti e traballanti. Il pezzo si chiude con una preghiera mormorata: Vic ripete con insistenza “I hope so”, mentre l’altra voce gli risponde “We know so”. È una tensione irrisolta tra speranza e certezza, e la fiducia collettiva non è per i vincitori, ma per chi riesce ancora a dire “lo spero”. Forse è un dialogo tra Vic ed il suo pubblico, o forse è solo un monologo sdoppiato, come spesso succede nei suoi testi: una mente che parla con se stessa, senza necessità di avere un interlocutore.
Ma ciò che rende What Do You Mean? veramente indimenticabile è il lungo impasto sonoro del finale, uno dei momenti strumentali più intensi e puri dell’intera produzione di Chesnutt: dolente, ansimante, puro. Un momento di bellezza che toglie il fiato e trasforma tutta l’ambiguità del testo in una melodia spettrale e commossa.
Ignorant People
Un blues sghembo, lucido e crudele. Vic attacca l’ignoranza non con rabbia, ma con un sarcasmo quieto, quasi affettuoso. Il ritmo è lento, la melodia dissonante. Ogni verso è una lama che però non affonda: osserva, deride, svela. Un brano “politico” senza ideologia, che somiglia più a un gesto poetico che a una presa di posizione.
Forthright
Una ballata disadorna che sembra emergere dalla notte di una casa vuota. La voce di Vic si muove tra esitazione e desiderio di chiarezza. La chitarra di Frisell è qui maestra: una delicata tessitura di note e riverberi che accompagna e contrappunta la voce.
È una canzone sulla sincerità. Ma la verità, per Vic, è sempre in fuga. La linea vocale è storta, spezzata, come chi prova a parlare con la gola piena di sabbia.
Trying to stop the bleeding with scotch tape
È un’immagine che potrebbe riassumere l’intero disco.
To Be With You
Un pezzo d’amore denso, teso, in cui l’organo di Van Dyke Parks e la chitarra graffiante e disarmonica di Vic la fanno da padrone, evocando atmosfere umide, ombrose, come stanze abbandonate e desideri evaporati. To Be With You non avrebbe sfigurato su Time Out of Mind di Dylan: ha quella stessa stanchezza incandescente, quel romanticismo disfatto che sa di sogno e di resa.
Il testo, senza pudore (come spesso accade con i suoi testi), è un’ossessione amorosa confessata con dolente lucidità. Non un’ode, ma un resoconto senza rimpianti e di un sacrificio assoluto:
I burned so many bridges to be with you / I shermaned pretty much my entire adult life –Ho distrutto praticamente tutta la mia vita da adulto per stare con te-: un sentimento che devasta tutto il resto, senza mezze misure, senza possibilità di ritorno. Una canzone sull’amore come catastrofe volontaria e, ciononostante, unica salvezza possibile.
Gnats
Il disco si chiude con Gnats, lungo pezzo non armonico, lento, sorretto dalla batteria e dalle percussioni accennate di Don Heffington, appena colorato da chitarre, basso e marimba, su cui Vic sussurra con un falsetto da cowboy ebbro, sfinito, quasi clownesco. È una conclusione sghemba, dimessa, antieroica, quella che chiude il disco.
Il testo è un accumulo di immagini minime, materiali quotidiani e dolori impliciti.
“Bastoni, pietre e ossa rotte, so perché le mie parole sono sbagliate”
Qui, la voce non canta perché non c’è nessun canto da salvare: solo consapevolezza muta, consunzione, fatica.
Humps and stumps and green tattoos / I know why your crutches bruise
Gobbe, ceppi e tatuaggi verdi/ So perché le tue stampelle ti lasciano lividi
L’inventario di corpi e mutilazioni si fa sempre più esplicito, in quella combinazione di nonsense e confessione che è tipica di Chesnutt. Le stampelle fanno male, anche quando servono per camminare. Anche quando sono persone. Anche quando sono parole.
I know where the time goes, conclude Vic: il tempo finisce, come finiscono i cibi poveri che evocano l’infanzia e la sopravvivenza. Gnats è una nenia afasica e storta, proprio come l’arte di Vic Chesnutt.
Un percorso segnato da relazioni profonde
Vic Chesnutt non è mai stato davvero solo. Il suo talento è stato riconosciuto e sostenuto da alcuni giganti della scena alternativa americana. Il più importante tra tutti: Michael Stipe, voce dei R.E.M., che lo scoprì agli inizi degli anni ’90 e produsse i suoi primi due dischi, Little (1990) e West of Rome (1991). Stipe ha sempre creduto nella forza tragica e visionaria di Vic, e lo ha aiutato a emergere senza snaturarlo.
Tra le relazioni artistiche più importanti c’è anche quella con Kristin Hersh, fondatrice dei Throwing Muses e sorellastra di Tanya Donelly dei Belly, cantautrice intensa e perturbante, legata a Vic da un’affinità dolorosa, poetica e spirituale. Hanno condiviso tour negli U.S.A. acustici e intimi, nei quali le loro canzoni sembravano parlarsi da un lato all’altro dello stesso palco.
Hersh — che ha raccontato Vic con profondità nel suo memoir Don’t Suck, Don’t Die (Non fare stronzate, non morire) — è forse l’unica ad aver compreso davvero la sua risata spezzata, la sua tenerezza ruvida, il suo genio indocile. Entrambi scrivono come se dovessero morire il giorno dopo. E ogni nota è un testamento.
Discografia: pietre nel cuore
Vic Chesnutt ha lasciato una discografia che non consola, piuttosto ferisce. Dischi come pietre, difficili da ingoiare, impossibili da digerire.
Quando ascoltarli?
Quando niente consola e tutto fa male.
Quando ti avvicini allo stato d’animo che conoscono bene i cercatori di umanità: quelli che si immergono in questo nostro abisso non per trovare risposte, ma per accarezzare ferite che somiglino alle proprie.
Quando non stai bene e ne hai tutte le ragioni.
E in fondo, sai che — ormai — non te ne importa più nulla.
Non per tutti. Non per sempre.
Prima di Ghetto Bells
Little (1990) – L’esordio scarno e già doloroso.
West of Rome (1991) – Prodotto da Stipe: forse il disco più “nudo”.
Drunk (1993), Is the Actor Happy? (1995), About to Choke (1996) – Affreschi di un’anima divisa, sempre più radicale e poetica.
Silver Lake (2003) – Una perla di equilibrio e suono, con Mark Howard alla produzione.
Dopo Ghetto Bells
North Star Deserter (2007) – Registrato con membri di Silver Mt. Zion e Godspeed You! Black Emperor, un requiem rumorista e magnifico.
Dark Developments (2008, con Elf Power) – Una parentesi più rock ma sempre instabile.
At the Cut (2009) – Il suo testamento sonoro, pubblicato poco prima del suicidio.
Skitter on Take-Off (2009) – Ultimo disco in vita. Spoglio, spezzato, essenziale. Come lui.
by Fabrizio Gelmini