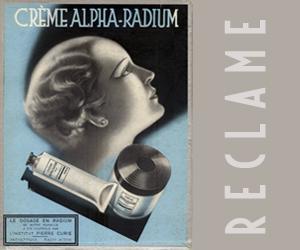Gemelli? Boh, Forse
Si dice che ognuno di noi ha una doppia anima...
by D&D
…Quello che state per leggere non è il prodotto di ricerche accademiche, ma divagazioni di un passante per caso intorno alla tecnologia.
Di recente mi sono imbattuto in una questione all’apparenza banale: volevo fare la contabilità all’interno dell’azienda. Ne ho parlato con il commercialista, che mi dice: “Bravo, ottima decisione: è meglio fare la contabilità all’esterno!”
Ed è lì che comincia la confusione… Io pensavo di farla “interna” perché, banalmente, è fatta all’interno dell’azienda. Ma per lui è “esterna” solo perché non la fa lui. Mi sembrava logico. E invece no: ho scoperto che nel mondo che ruota intorno alla contabilità, per quanto strano possa apparire, la logica è… diversa.
Animato dalle migliori intenzioni e armato di pazienza (che si è poi dissolta in pochi clic), ho iniziato a cercare un gestionale adatto. L’idea era semplice: trovare un software che mi permettesse di importare le fatture da un altro sistema, per evitare di cambiare codice SDI. Sembrava un desiderio innocente. Invece, è stato come chiedere a un asino di volare.
Mi sono rivolto all’universo dei SaaS – Software as a Service – che, sulla carta, sembrano il paradiso dell’efficienza: non installi nulla, ti colleghi via Internet, tutto funziona a meraviglia. Ma nella pratica… eh, nella pratica scopri che non è tutto cloud quello che luccica.
Il mio problema era chiaro: usare solo la parte contabile del software, lasciando fuori fatturazione, scadenze e magazzino che gestisco con altri sistemi. Risposta dei fornitori? “Ah no, o usi tutto il pacchetto oppure funziona male.” Insomma, o ti sposi tutto il sistema, oppure resti single. Nessuna relazione aperta, nessuna convivenza parziale. Solo matrimonio con clausola di esclusiva.
E così, nel mio pellegrinaggio digitale, ho trovato soluzioni che si vantavano di essere “in cloud”, ma che di fatto erano vecchie app in camice bianco. Alcuni software si accedevano tramite desktop remoto, con un’interfaccia uscita direttamente da un museo dell’informatica. E poi, il colpo di scena: “Adesso usiamo SQL!” pronunciato con l’entusiasmo di chi ha appena scoperto il fuoco. Peccato che SQL esistesse già quando avevamo i modem a 56k.
Il discorso non cambia quando si parla di rilevazione presenze. Un software è facilissimo da usare, ma non supporta i terminali fisici. Un altro li supporta, ma per configurarlo servono un master in ingegneria spaziale e un esorcista. Insomma: o troppo facile e limitato, o troppo potente e ingestibile. Trovare una via di mezzo è complicato come trovare parcheggio in centro il sabato sera.
Ma la vera perla è capire come nascono questi software. Spesso si ha la sensazione che chi sviluppa e chi vende non si parlino da anni. Il commerciale vende la Luna, lo sviluppatore programma Marte. E l’utente nel mezzo, cioè io, finisce su Plutone. Lontano da tutto, anche con il miglior supporto tecnico del mondo, ma senza possibilità di dire la sua su funzionalità e aspirazioni.
E allora mi chiedo: è davvero così difficile raccogliere feedback dagli utenti? Si fa con le recensioni dei ristoranti, con le app per fare jogging, persino con i pupazzi delle merendine. Ma nei software no: lì bisogna aspettare che qualcuno protesti tanto e forte per essere ascoltati. E anche in quel caso, ti dicono che “il problema è noto” – che è un modo elegante per dire “lo sappiamo, ma preferiamo ignorarlo con stile”.
A voler essere onesti, non stiamo nemmeno parlando di software da supermercato, quelli che scarichi, installi e via. E neppure di quei software fatti su misura, con un team di sviluppo che ti segue passo passo come un sarto con il metro in mano. No, qui siamo in quella terra di mezzo, fatta di soluzioni “standard ma di nicchia”, pensate per settori specifici, con esigenze particolari. Ma che non hanno né la flessibilità delle soluzioni artigianali, né la semplicità di quelle per il grande pubblico.
E qui il problema si fa ancora più interessante: chi compra questi software non è quasi mai chi li usa. Di solito è un dirigente, un responsabile, un consulente. Uno che guarda una brochure, assiste a due schermate in una demo patinata e firma un contratto da migliaia di euro. Poi a usarlo sono i dipendenti, che si ritrovano con interfacce farraginose, flussi rigidi, funzioni che “tecnicamente ci sarebbero” ma “bisogna fare un ticket per attivarle”. E a quel punto, ci si adatta. Perché si sa: il software non si cambia, l’utente sì.
Se poi l’azienda è abbastanza grande da potersi permettere un investimento serio – diciamo decine di migliaia di euro – allora il discorso cambia. Si fa fare il software su misura, si costruisce l’interfaccia intorno al proprio flusso di lavoro, si chiama il programmatore per nome. Ma per le aziende di fascia media, quelle che non possono buttare soldi ma nemmeno affidarsi a soluzioni low-cost, l’unica scelta è rassegnarsi al software “così com’è”.
E allora via, avanti con i fogli Excel paralleli, le procedure a voce, le email con allegati che si perdono nella notte dei tempi. Perché alla fine, il software esiste, sì… ma il vero gestionale è quello mentale.
In tutto questo, diventa importante distinguere tra un vero servizio “in cloud” e un server remoto mascherato da moderno. Un vero cloud ti permette di scalare, di pagare solo ciò che usi, di lavorare ovunque con flessibilità. Un finto cloud ti fa venire nostalgia dei floppy disk.
E poi c’è la domanda finale: quanto a lungo potranno sopravvivere questi software, con l’arrivo dell’intelligenza artificiale?
Allo stesso tempo mi viene in mente Oracle… un sistema che, seppur vetusto, resiste ai colpi del tempo, grazie alla fedeltà delle grandi, grandissime aziende. Quelle che, quando devono cambiare qualcosa, prima ci fanno una riunione da 20 persone e poi decidono di lasciar tutto com’è.
Da questa storia ho imparato che è meglio non sapere troppo ed accontentarsi, diffidare delle nuvole troppo cariche che promettono sole e poi ti lasciano sotto l’acqua e, soprattutto, la tecnologia invece di semplificare la vita, la complica come un rebus in sanscrito.
by D&D